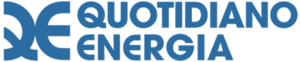
Danni da eventi meteorologici e climatici ai massimi: 43,7 mld € negli ultimi cinque anni
Copertura del rischio per le imprese tutta caricata sull’obbligo assicurativo, ma lo Stato dovrà coprire per le infrastrutture pubbliche e gli immobili residenziali
La transizione green si sta svolgendo in una fase particolarmente critica, in cui l’impatto dei cambiamenti climatici incrocia sempre più da vicino la vita delle imprese. L’ultimo Rapporto annuale di Arera riporta che nel 2024 in Italia si sono registrati 351 eventi meteorologici estremi che hanno causato danni. Secondo una analisi pubblicata dalla BCE, nei prossimi cinque anni, gli eventi meteorologici estremi potrebbero causare una perdita fino al 5% della produzione economica dell’area dell’euro. Un’altra analisi della Banca centrale europea indicano che la sola scarsità di acqua superficiale mette a rischio quasi il 15% della produzione economica dell’area dell’euro. In Italia nei settori manifatturieri idroesigenti sono attive 117mila imprese con 1 milione 337 mila addetti, oltre un terzo (34,4%) del totale degli occupati della manifattura. Inoltre, a fronte delle carenze infrastrutturali e di manutenzione il 42,4% dell’acqua immessa nelle reti idriche viene dispersa.
L’analisi dei dati di Eurostat di fonte dell’Agenzia europea dell’Ambiente (EEA) evidenzia che la serie storica su base quinquennale dei danni da eventi meteorologici e climatici, valutata a prezzi costanti dell’anno 2022, presenta un trend marcatamente crescente nell’ultimo ventennio e negli ultimi cinque anni (2020-2024) raggiunge il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari 8,7 miliardi di euro all’anno. Nel totale, tra il 1980 e il 2024 i danni economici per eventi meteorologici e climatici in Italia ammontano, valutati a prezzi costanti 2024, a ben 145,2 miliardi di euro, il secondo valore più alto in UE con una quota del 17,7% sul totale dei 27 paesi dell’UE, dopo i 186,9 miliardi della Germania (22,7% del totale UE). Queste perdite sono equivalenti, nel nostro Paese, a 2.503 euro pro capite, valore che supera del 31,3% la media UE.
Un recente studio di ricercatori della BCE e dell’Università di Mannheim su base regionale indica che le perdite dovute alla siccità, alle ondate di calore e alle inondazioni che hanno colpito l’Italia quest’estate sono stimate a 11,9 miliardi di euro; questa cifra potrebbe salire a 34,2 miliardi di euro nel 2029.
Secondo i dati dell’Ispra, sono 74.974 le unità locali delle imprese in aree a pericolosità più elevata per rischio frana. Nel dettaglio 26.386 imprese sono in aree a pericolosità molto elevata (6,4% delle imprese nelle aree a rischio frane) e 48.588 in quelle a rischio elevato (11,8%). Tali imprese rappresentano l’1,5% del totale imprese, quota che è più che doppia a livello regionale in Valle d’Aosta con il 7,9%, Basilicata con il 5,1%, Molise con il 3,8%, Campania con il 3,7%, Liguria con il 3,4% e Abruzzo con il 3,1%.
Inoltre, sono 225.874 le imprese che operano in aree ad elevato rischio alluvione, pari al 4,7% delle imprese. La quota è ampiamente superiore alla media nazionale in Liguria con il 18,2% e in Calabria con il 12,1%, seguite da Veneto con il 9,3%, Emilia-Romagna con il 9,1% e Toscana con l’8,1%.
Le dimensioni dell’impatto del cambiamento climatico appaiono difficili da affrontare senza un intervento statale. Le regole fiscali impongono un tetto alla crescita della spesa primaria e con la manovra di bilancio in discussione in Parlamento, come ha indicato l’Ufficio parlamentare di bilancio, “l’utilizzo pressoché integrale dello spazio di bilancio disponibile espone al rischio di non avere a disposizione ulteriori risorse per far fronte a esigenze impreviste”. A fronte degli scarsi spazi nel bilancio pubblico, la copertura del rischio da climate change per le imprese viene pressoché interamente caricata sul sistema privato mediante l’obbligo di assicurazione che dal 1° gennaio 2026 viene esteso a tutte le imprese italiane. Lo Stato, comunque, dovrà intervenire per la copertura dai danni alle infrastrutture pubbliche e agli immobili residenziali. Secondo l’ultima rilevazione dell’IVASS, nel 2023 risultano assicurati 751mila immobili commerciali, con un importo medio assicurato di 2,1 milioni di euro. Inoltre, la raccolta premi relativi alle coperture dei rischi climatici è per i due terzi (65,9%) per danni da grandine, il 20,9% da tempesta e il 12,3% da inondazione. Una rilevazione di Banca d’Italia pubblicata nei giorni scorsi indica che tra le aziende senza copertura assicurativa contro i rischi fisici, il 58% afferma di considerare il rischio climatico irrilevante per le proprie attività.
Sull’obbligo di sottoscrizione di una polizza catastrofale sono numerose le criticità sottolineate dal sistema delle imprese, difficili da superare con i soli meccanismi di mercato: i punti di debolezza sono relativi a incertezze normative, una offerta non ancora allineata, i costi potenzialmente elevati per imprese con bassa dotazione di capitale e operanti in zone a basso rischio, la necessità di strumenti di confronto delle offerte di mercato, la trasparenza e consapevolezza sull’oggetto della copertura, i criteri di determinazione e risarcimento danni, modalità e tempi per la denuncia, la ricognizione dei danni e le procedure di risarcimento, la copertura degli immobili in caso di piccole difformità rispetto alla licenza edilizia. Come evidenziato nell’ultima relazione annuale dell’IVASS, un’indagine condotta su 46 polizze a copertura dei rischi catastrofali offerte da 14 compagnie assicurative evidenzia che “le condizioni di polizza non sempre sono chiare e semplici da comprendere e le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie né complete; per raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei fabbricati è chiesta all’assicurato la compilazione di questionari complessi, con informazioni tecniche che l’assicurato potrebbe non conoscere”. D’altro canto, la stipula di una polizza catastrofale da parte delle imprese appare certamente una buona pratica che, al netto delle incertezze sopra evidenziate, può prevenire molte delle conseguenze potenzialmente negative che si possono presentare al verificarsi dell’evento avverso: fermo dell’attività, danni non soltanto agli immobili, ma anche ai macchinari e alle linee di produzione, al magazzino di prodotti finiti e materie prime.
Rubrica Imprese ed energia su QE- Quotidiano Energia del 18 novembre 2025

