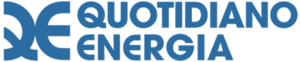
La coda lunga dei prezzi retail dell’energia
Tra il 2021 e il 2025 +47,8% dei prezzi al consumo elettricità e gas mentre -0,1% dei prezzi all’import oil&gas e -7,0% del prezzo all’ingrosso dell’elettricità. Costi dell’energia e criticità della transizione green nel report per la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato
L’analisi dei dati pubblicati dall’Istat giovedì scorso confermano il trend discendente dei prezzi all’import dell’energia che ad agosto 2025 segnano un calo su base annua del 13,3%. La flessione è diffusa, con diversi gradi di intensità, per le commodities energetiche: per il carbone il calo è del 9,4%, per il gas naturale dell’11,4% e per il petrolio del 17,5%, con una media per petrolio greggio e gas del -15,5%. Nella media dei primi otto mesi del 2025 il prezzo all’import di petrolio e gas è rientrato sui livelli del 2021, precedente allo scoppio della crisi energetica. In parallelo il prezzo all’ingrosso dell’elettricità nel 2025 è del 6,2% inferiore alla media del 2021. Ma è sul mercato retail che si osserva una “coda lunga” della crisi energetica: tra il 2021 e il 2025 (media primi otto mesi 2025) i prezzi al consumo di energia e gas risultano del 47,8% superiori ai livelli pre-crisi, a conferma che il sistema produttivo sta subendo una prolungata pressione sui costi. Un focus sui costi dell’energia è proposto nel report “Le sfide energetiche e della transizione green per le imprese – Key Data 2025” pubblicato dall’Ufficio Studi in occasione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2025 che si è aperta ieri e durerà fino a venerdì prossimo, articolandosi su 82 eventi territoriali.
Il report, arricchito dagli spunti di analisi proposti dall’Ufficio Studi nella rubrica ‘Imprese ed energia’ su QE-Quotidiano Energia, delinea aspetti della transizione ambientale che rappresentano fattori strategici per la competitività del sistema produttivo italiano. L’Italia è, infatti, la seconda economia manifatturiera d’Europa e il primo paese per occupazione nelle micro e piccole imprese (MPI) del settore, ma questa leadership è oggi interessata da un prezzo dell’elettricità superiore del 22,5% alla media europea (QE 9/9), da squilibri fiscali e da criticità nell’accesso alle risorse per la transizione green. Il differenziale di prezzo dell’energia elettrica con la media europea genera un extracosto stimato in 1,6 miliardi di euro nei settori a maggior presenza di MPI. Sul differenziale di prezzo dell’elettricità pesa il prelievo fiscale e parafiscale che per le MPI in Italia è più che doppio (+117,4%) rispetto alla media UE a 27. Più in generale, in Italia la tassazione ambientale è pari al 2,5% del PIL, di mezzo punto superiore alla media europea (QE 10/6). Le accise dei carburanti in Italia restano tra le più alte d’Europa: l’accisa sul gasolio è del 24,9% superiore alla media dell’Eurozona quella della benzina supera dell’11,6% il benchmark europeo. Il principio “chi inquina paga” risulta nei fatti invertito: la più elevata tassazione ambientale in Italia è paradossalmente associata ad emissioni di CO2 pro capite inferiori dell’8,4% rispetto alla media UE. Tenuto conto che nei primi otto mesi del 2025 i consumi di gasolio motori sono 2,6 volte quelli della benzina, il riallineamento delle accise previste dalla manovra di bilancio (QE 20/10) alzeranno ulteriormente la tassazione ambientale. L’accelerazione della digitalizzazione determinata dalla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di elettricità dei data center, che in Italia cresce del 25,1% all’anno. (QE 23/9). Le conseguenze del climate change e le crisi idriche incidono sullo sviluppo delle energie rinnovabili e generano rischi sul sistema produttivo. In Italia nei settori idroesigenti sono attive 117mila imprese con 1 milione 337 mila addetti, oltre un terzo (34,4%) del totale degli occupati della manifattura. A fronte delle carenze infrastrutturali e di manutenzione il 42,4% dell’acqua immessa nelle reti idriche viene dispersa (QE 29/7). La stretta monetaria nel biennio ha determinato una riduzione della quota di imprese che realizzano investimenti green – in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale – che è passata dal 25,2% del 2023 al 24,7% nel 2024. Sul rallentamento pesa la complessità dell’accesso agli incentivi: il piano Transizione 5.0, nato per accelerare l’innovazione e l’efficienza energetica, mostra un utilizzo parziale e a metà ottobre 2025 risultano inutilizzati 4 miliardi di euro, pari al 64,8% delle risorse disponibili. Le risorse saranno rimesse in circolo con la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali prevista nella prossima manovra di bilancio. Last but not least, la carenza di competenze impedisce alle imprese di essere più sostenibili per l’ambiente. Nel 2024 su 1,6 milioni di assunzioni previste dalle MPI, oltre 899 mila riguardano profili con una marcata richiesta di competenze green, ma il 55,6% è di difficile reperimento. Tali competenze sono strategiche per le 93 mila imprese della filiera delle fonti di energia rinnovabile.
Rubrica Imprese ed energia su QE- Quotidiano Energia del 21 ottobre 2025

